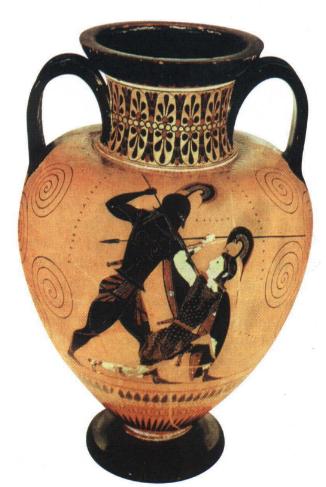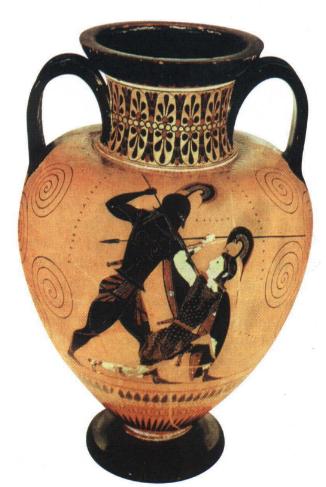
Nella prima parte dell’Iliade, troviamo un Achille che mostra delle sfaccettature molto particolari del suo carattere.
Solitamente pensiamo ad Achille come ad un guerriero implacabile, forte e coraggioso, ma questa versione del figlio di Peleo è distante da quella che ritroviamo nelle prime pagine del poema omerico.
Quello che incontriamo è più un bambino che corre dalla mamma alla prima lite coi compagni di scuola, che un eroe di battaglia.
Immaginate il biondo Achille, re dei Mirmidoni di Ftia, seduto sul bagnasciuga di una spiaggia, intento a piangere lacrime su lacrime perchè i suoi compagni gli avevano appena rubato la merenda.
Spieghiamo meglio la scena.
Il grande esercito degli achei (abitanti dell’antica Grecia), rispondeva al comando di un unico re: Agamennone.
La guerra era iniziata per rimediare al torto subìto da Menelao, fratello di Agamennone, a cui era stata sottratta la moglie da Paride il bello, secondogenito di Priamo re di Troia.
L’insieme degli eserciti di tutte le polis achee, avevano aderito alla causa di Menelao, chi per un motivo, chi per un altro e da nove anni se ne stavano a combattere e morire, davanti alle mura inespugnabili di Troia.
Nove anni sono tanti, soprattutto per un gruppo di uomini che non aveva la certezza di sopravvivere al giorno successivo; così, grazie a razzie e doni, molti uomini riuscirono a rendere schiave delle donne, giusto per passare il tempo, allentando le tensioni notturne.
La schiava di Agamennone era una certa Atinome, detta Criseide, figlia del sacerdote apollineo Crise.
Questo pover’uomo che non riusciva più a sopportare che il destino di sua figlia fosse quello di farsi carico delle tensioni notturne di Agamennone, fece quello che ogni buon padre avrebbe fatto: supplicò il re, facendo leva sulla sua nobiltà d’animo.
Dovete sapere che il nostro Agamennone tutto era fuorché nobile d’animo. Le richieste del sacerdote vennero ignorate e derise, mentre l’uomo venne insultato senza ritegno.
Tornandosene verso il mare, Crise, chiese ad Apollo, dio dell’arco d’argento, di punire l’insolenza del re degli achei.
Detto fatto. Apollo iniziò a scagliare frecce infuocate contro Agamennone e il suo esercito. Le divinità greche erano puntuali come orologi svizzeri.
Giustamente, gli achei si riunirono per discutere del fatto, visto che non esistevano ombrelli per le piogge di frecce infuocate.
Proprio durante la discussione si alzò un certo Calcante, figlio di Testore, professione: veggente. I cari bei lavori d’una volta…
Questo veggente, dopo essersi alzato, disse -Beh… io in realtà conosco le motivazioni che hanno fatto adirare il dio Apollo. Ma non voglio dirvele.
Qualcuno chiese -Come mai non vuoi dircele?- e Calcante rispose -Perchè ho paura che qualcuno possa arrabbiarsi e credo anche che questo qualcuno potrebbe farmi la pelle, si vi spiegassi le motivazioni del divino Apollo. Certo… se un eroe, magari qualcuno amato dagli dei, specialmente da Zeus, mi promettesse di difendermi… io potrei anche dirvi come stanno le cose.
Achille si alzò e disse -Ti difendo io.- e, continuando con una totale mancanza di pragmatismo rispose a gran voce -Ti difenderò anche se il tuo nemico dovesse essere Agamennone… che dice di essere il più forte degli achei.
Il gelo. Sì, perchè quando Achille, che era a tutti gli effetti il più forte degli achei, ti viene a dire una cosa del genere, un minimo d’effetto destabilizzante riesce a crearlo.
-Ok.- disse Calcante -Apollo è arrabbiato perchè Agamennone, come al solito, si è dimostrato maleducato, solo che questa volta ha mancato di rispetto ad un sacerdote d’Apollo e questo l’ha fatto adirare molto. Tuttavia, il dio è disposto mettere da parte la sua collera se Agamennone restituirà Criseide a suo padre.
Adesso immaginate Agamennone, il più egocentrico dei sovrani, davanti ad un eroe e un veggente che in parole povere gli stanno facendo fare la figura del pirla davanti a tutti.
Così, dopo aver insultato a dovere il veggente, Agamennone disse che avrebbe restituito la sua schiava solamene se gli achei gli avessero fatto un regalo.
Ora, fare il regalo ad un re così importante era un po’ un problema, perchè le divinità avevano regali come l’Asia, ma una manciata di soldati e re achei, in una terra straniera, non avevano nulla da regalare ad Agamennone.
Achille fece notare quel dettaglio al sovrano e lui, rispondendo di getto, disse -Io restituirò la mia schiava, ma tu caro il mio Achille, visto che parli tanto, mi regalerai la tua schiava.
Il figlio di Peleo ebbe un tonfo nel petto, c’è chi pensa sia dovuto all’amore e chi all’orgoglio, fatto sta che Briseide, la schiava di Achille era stata richiesta dal sovrano in persona.
La sorte degli achei era nuovamente tra le braccia di una donna, perchè la civiltà greca non ha mai dato molta importanza alle donne, ma le donne hanno ciclicamente messo in ginocchio divinità ed eroi.
Achille acconsentì (dopo aver accarezzato la sua spada) a cedere la sua bella Briseide, ma prima fece un discorso che potrebbe far pensare a molti che il figlio di Peleo fosse il precursore del sindacalismo.
Ascoltate, perchè sembra uscito dalla C.G.I.L..
-Agamennone… Agamennone. Io sono venuto qui con il mio esercito e come me hanno fatto lo stesso eroi del calibro di Enea e Odisseo, anche se a noi i troiani non hanno fatto niente. Io , assieme a questi eroi ho combattuto per la tua causa e tu hai sempre ricevuto parti maggiori dei nostri bottini, eppure non mi pare di averti mai visto sul campo di battaglia. Facciamo così: prenditi pure la mia Briseide. Voglio che si ricordi il mio nome, come quello della persona che ha rinunciato al suo bene per quello degli achei. Mentre voglio che il tuo nome venga ricordato come quello dell’uomo che ha condannato i suoi uomini a morte certa per mano delle armate di Ettore, perchè Achille non combatterà più per te. Tutti gli achei rimpiangeranno il mio elmo.
Lapidario. Il sottotesto è: io salvo i greci adesso, ma tu troverai certamente un modo per farli ammazzare poco dopo.
Questa saggezza non era tutta farina del sacco d’Achille, ma una divinità aveva messo le sue grinfie su quella discussione.
Dovete sapere che nell’Iliade gli dei non si facevano mai i cazzi loro. Così, Atena scese dal cielo, rendendosi visibile solamente ad Achille, poco prima del sindacalismo degli eroi.
Il tutto avvenne in un istante, esattamente quando Achille, assieme alla sua spada, accarezzò anche l’idea di porre fine alla vita di Agamennone.
-Achille, non fare cavolate, perchè in quello il re degli achei è bravissimo da sé. Insultalo quanto vuoi, ma non usargli violenza. Se così farai, avrai doni pari a tre volte il torto subito.- disse la dea, per poi sparire.
Achille fece un rapido calcolo… il torto era una donna, tre volte una donna era l’equivalente di tre donne. Ci poteva stare. Così, il nostro Achille divenne pragmatico.
Subito dopo il discorso del Pelide, si alzò un vecchio guerriero, Nestore.
Questo grande eroe cercò di calmare le acque, rivolgendosi ai due uomini in maniera paterna -Sentite, in primo luogo qui vi state auto definendo i più forti del mondo, quando in realtà io che ho qualche annetto più di voi, posso dirvi di aver conosciuto achei ben più forti di voi, come Teseo, Piritoo, Driante, Polifemo ed altri. Quindi, evitiamoci l’egocentrismo e torniamo a noi. Achille, tu sei il figlio di una dea, ma non per questo devi avere più bottino del re di tutti re, mentre tu… Agamennone, perchè non eviti di rubare la donna ad Achille, perchè senza di lui siamo spacciati?
Qualcuno doveva far notare ad Agamennone che senza quel biondino dal piede veloce i troiani avrebbero vinto la guerra.
Agamennone rispose -Non me ne frega niente. Il fatto che sia una mezza divinità non gli dà il diritto d’insultare il mio nome. Portatemi la sua donna e lascerò che Odisseo riporti Criseide a suo padre.
Così Achille, disse al suo più intimo amico (forse cugino e forse amante), Patroclo, di non difendere la sua tenda quando i soldati di Agamennone sarebbero andati a rubargli Briseide e, infine, se ne andò a piangere in riva al mare, da sua madre.
Teti, madre di Achille, emerse dalle acque ed andò a consolare il suo figlioletto.
Achille era incazzato nero. Sapeva che con la sua forza avrebbe potuto ammazzare in un solo secondo il tiranno Agamennone, ma questo avrebbe condannato gli altri uomini. Inoltre, c’era qualcos’altro…
Achille era maledetto. Ancora bambino gli venne predetto un destino binario. Se non fosse mai partito all’avventura, avrebbe avuto una vita serena e lunga, lontana dagli scontri e dalle brutture delle guerre, mentre se avesse optato per la via dell’avventura, il suo destino sarebbe stato breve, ma intenso e pieno di gloria.
Le sue lacrime si basavano proprio su questo concetto. Achille, facendo due conti, pensò -Qui io sto combattendo da nove anni e della gloria, neanche una traccia. La mia vita sarà molto breve e adesso mi hanno rubato anche la donna, insultandomi. Non è che la gloria non arriverà mai e creperò come un imbecille?
La madre cercò di consolarlo in ogni maniera, fino farsi strappare una promessa che alleggerì lievemente i dolori del figlio.
-Mamma, mi devi promettere che chiederai a Zeus di aiutare i troiani a sconfiggere in battaglia gli achei, così capiranno che senza di me non potranno mai vincere la guerra! Zeus non potrà dirti di no, anche perchè è sempre stato innamorato di te.
Come ogni madre avrebbe fatto, Teti acconsentì ad accontentare il figlio. C’era un solo problema, Zeus era partito per un viaggetto in Etiopia, portandosi dietro tutti gli dei e non sarebbe tornato prima di dodici giorni.
-Tranquilla, io ti aspetterò qui.- rispose Achille.
Il bello è che lo fece per davvero. Aspettò dodici giorni e dodici notti in riva al mare, piangendo. Almeno questa è la versione che ho immaginato nella mia testa.
Pensate che per tutta la durata del suo ritiro sul bagnasciuga, non si recò nemmeno una volta all’assemblea e, soprattutto non si fece vedere in battaglia e questo si notò ancor più della sua assenza in assemblea.
Quando Teti riuscì ad incontrare Zeus, durante una festa, gli fece gli occhi dolci, senza esagerare troppo perché non voleva offendere Era, che l’aveva cresciuta, e Zeus non poté che risponderle -Sì. Il torto fatto ad Achille verrà rimediato.
Era si accorse di qualcosina, ma Zeus finse che nessuna cospirazione fosse in atto.
Quella notte, mentre la sua consorte dormiva, il capo di tutti gli dei iniziò a pensare una strategia per correre in aiuto dell’orgoglio ferito del giovane Pelide.
Ferdinando de Martino.
Se ti è piaciuto l’articolo, leggi anche: Come siamo arrivati alla guerra di Troia?