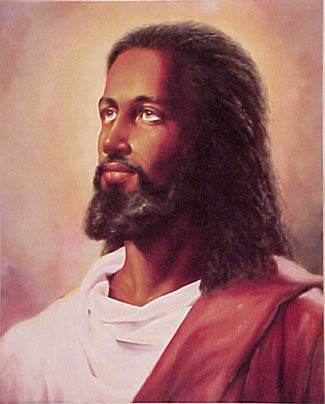Enòglie
5,1-20
Mentre l’auto di servizio mordeva l’asfalto a grande velocità, Jeff continuava a guardare nervosamente nello specchietto retrovisore controllando il prigioniero attraverso la grata che li divideva. Affianco a lui non c’era nessuno, il sedile del passeggero era desolatamente vuoto, e la cosa lo innervosiva parecchio.
“Dannazione. Come possono mandarci in strada a rischiare la pelle senza un compagno? Perché non c’è Lewis qui con me? O Gomez? Capisco i tagli al budget. So anche che non siamo a New York. Il capo ha le mani legate. Ma…cazzo. Spedirci di pattuglia da soli è una maledetta follia”.
Era in polizia da poco più di tre anni. Quelli appena necessari per revocargli lo status di ‘novellino’, senza però farlo accomodare nei panni del veterano. Non era né carne né pesce. E, quella notte, mentre tornava in centrale con quel tizio in custodia se la stava davvero facendo nei pantaloni.
L’operatrice lo aveva contattato alla radio quarantacinque minuti prima gracchiandogli addosso un codice quindici. Una stramaledetta segnalazione di violenza domestica. In teoria doveva essere una faccenda di routine: la classica moglie cornuta che schianta qualche porcellana sul marito fedifrago di turno.
Ma il destino aveva in serbo qualcosa di diverso per l’agente Daniels.
– Uno nove due, uno nove due. Jeff, hai un codice quindici al 33 di Hampton Road. I vicini hanno sentito rumori violenti e urla di una donna all’interno 3c, registrato a nome di Charline Harriett. Vedova.
Pare che un uomo si sia introdotto a forza nell’appartamento. Vai a controllare. Chiama se hai bisogno di supporto. Chiudo –
Una volta arrivato, aveva trovato la porta forzata. Il legno all’altezza della serratura era completamente sbriciolato. Forse un piede di porco.
Nella casa regnava il caos. Sembrava che ci fosse stato un tornado o, quantomeno, un terremoto violento: i quadri che un tempo erano appesi sulle pareti giacevano a terra in frantumi. Stoviglie, pentole e soprammobili erano sul pavimento, ormai ridotti a spazzatura e tristi brandelli. Nell’angolo del piccolo cucinino, Jeff trovò una donna in lacrime. Qualcuno aveva fatto scempio del suo corpo. Aveva un occhio gonfio e un incisivo spezzato. La vestaglia che si stringeva addosso era stracciata come se l’avesse azzannata un rottweiler.
Tremava come una foglia, senza dire una parola. Nemmeno si accorse di Jeff che, con estrema cautela, mano sulla fondina, avanzava cercando di fare meno rumore possibile. Una volta che le fu di fronte, con l’indice sulle labbra, le intimò di non parlare. Gli parve che non lo vedesse nemmeno.
Nessun segno dava l’idea che avesse colto il silenzioso comando impartitole da quel ragazzetto dai capelli color paglia.
Il giovane agente, a quel punto, si inginocchiò di fronte alla donna e le agitò il palmo della mano davanti agli occhi. Niente da fare: continuava a fissare ostinatamente le profondità del nulla.
Era persa in una dimensione lontana, popolata da mostri violenti e da un’agonia perpetua. Vi era stata confinata da quando aveva ricevuto la visita del demonio che l’aveva ridotta in quel modo.
Ma Jeff tutto questo non lo sapeva.
Esaminò meglio quel corpo devastato e vide che aveva dei tagli profondi sulle cosce. Regolari e ritmici. Precisi. Il sangue era colato copioso sul pavimento insieme a quello che, a tutti gli effetti, pareva essere del liquido seminale. Quasi certamente era stata violentata.
Le prese – con delicatezza – il mento fra le dita e sussurrò: – È ancora qui? –
Quel contatto delicato parve rianimarla. Gli occhi di lei si sgranarono per il terrore e prese a tremare ancor più violentemente, come se il ritorno nella loro dimensione le risultasse intollerabile. Poi il suo sguardo si spostò verso l’unica altra stanza dell’appartamento, quasi ad indicargli che sì, c’era ancora, ed era proprio là dentro. Jeff le fece una rapida carezza, sbottonò il laccio di cuoio della fondina e fece per dirigersi verso la camera da letto.
Nell’attimo in cui fletté le ginocchia per alzarsi, le mani di lei saettarono verso la sua, trattenendolo. I loro occhi si intrecciarono per un istante eterno. Quelli della donna, azzurri, gonfi e rossi per il pianto, erano pieni di un terrore che lui non avrebbe mai più visto in vita sua.
Era come se quella creatura sfatta e impaurita avesse incrociato la strada del diavolo in persona.
Mentre Jeff si alzava, divincolandosi dalla presa della donna, lei ruppe il silenzio che aveva regnato fino ad allora. Biascicò un flebile “no, non andare”. Quella reazione lo impietrì. Un gargoyle bloccato dalla paura.
Cosa accidenti le avevano fatto per ridurla in quello stato?
Il poliziotto le fece nuovamente cenno di restare in silenzio, ma lei continuò a supplicarlo disperatamente di non andare. Gli si aggrappò alla gamba come una vergine pronta al martirio. Dovette sottrarsi con decisione alla presa per riuscire a procedere.
A quel punto, il giovane in uniforme prese ad avanzare lentamente verso la porta della camera. Era in un bagno di sudore. Poteva sentire il ritmo folle delle sue pulsazioni attraverso la vena sulla tempia che pareva volesse schizzargli fuori dal volto. La guaina di pelle del cappello d’ordinanza scivolava pericolosamente sulla fronte rischiando di accecarlo da un momento all’altro.
Decisamente un tempismo inopportuno.
Mentre impugnava saldamente la pistola di fronte a sé, sentì le braccia irrigidirsi sempre più. Articolazioni di piombo. Poi, finalmente, la scarica di adrenalina raggiunse il suo apice: entrò nella stanza. Era piccola e angusta. Lungo tutta la parete di destra c’era un grosso armadio di legno. Sul lato opposto alla sua posizione, una finestrella mostrava unicamente il nero pece della notte. Non si vedeva un accidente. Al centro dell’ambiente c’era solo un grosso letto matrimoniale. La luce di una piccola abat-jour sul comodino vicino alla finestra illuminava appena la figura di un uomo che se ne stava seduto sul bordo del materasso a capo chino.
– Ehi, tu. Non ti muovere. Alza subito le mani!
Il tizio non si mosse di un millimetro e non rispose. Jeff respirava pesantemente e gran velocita. Gli capitava spesso di iperventilare nelle situazioni di tensione. Alzò il cane della pistola, sperando che il ‘click’ prodotto dal revolver fosse una minaccia sufficiente per fare eseguire il suo ordine.
Nulla da fare. A quel punto riprovò.
– Ehi, stronzo! Ti ho detto di tirare su le braccia. Alza le mani e uniscile dietro la nuca, sennò ti spedisco al creatore! Mi hai sentito, bastardo?! Forza, obbedisci! Ora!
Silenzio. Assordante silenzio.
Jeff, a quel punto, era schiantato dal panico. Era la prima azione che intraprendeva in solitaria, e la procedura era decisamente più complessa senza un compagno che lo aiutasse nell’arresto. La radio che portava agganciata sopra la spalla era perfettamente inutile fino a quando non fosse riuscito ad immobilizzato il sospetto.
Così agì d’impulso.
Fece rapidamente il giro del letto e si ritrovò di fronte all’individuo. Indossava un lungo paltò nero. Al di sotto di esso portava solo dei jeans lerci e un paio di anfibi senza lacci. Il busto, privo di indumenti, si mostrava tetramente allo sguardo di Jeff pieno di tatuaggi assurdi. Al centro del petto si stagliava una grossa stella nera. Da lì si diramavano una serie di angoscianti figure. Larve, scarabei mostruosi, chiese in fiamme e lupi con zanne grondanti saliva osservavano minacciosi la bocca della pistola.
Sotto la spalla vide il disegno di un gigantesco uomo con la testa d’uccello seduto su un trono nell’atto di defecare piccoli esseri umani urlanti.
Jeff, con le mani tremanti, fece scorrere l’arma lungo quel petto mostruoso fino a raggiungere il mento dell’uomo. Applicò una pressione decisa verso l’alto spingendo alla luce i due baratri neri che quell’essere aveva al posto degli occhi. Una barba folta e ispida gli copriva la faccia e buona parte del collo.
La zona centrale della testa era completamente calva, mentre dai lati scorreva una lunga cascata di capelli lerci.
Quando i loro sguardi si incontrarono, Jeff ne fu come schiantato. Non c’era nessuna luce in quelle pupille.
Era come se stesse osservando gli occhi di uno squalo bianco. O di un Grizzly: due palle nere, vuote e senza vita.
Fu colto a tradimento da un sussulto involontario e indietreggiò impercettibilmente.
Di fronte a quella reazione spaventata, le labbra dell’uomo si incresparono leggermente, facendo correre un brivido gelido lungo tutto il corpo di Jeff.
Decise di reagire. “Non ho paura di te, maledetto bastardo”, mentì a sé stesso.
Spinse la canna della pistola sulla testa del sospetto con decisione, esattamente al centro della stella nera (“ma che diavolo…?”) che portava tatuata sulla fronte.
– Te lo ripeto. Alza le mani e uniscile dietro la testa. Altrimenti sparo. Qui e ora. Ti dirò la verità: non mi piaci neanche un po’. Non mi piace cosa hai fatto a quella donna, e sono da solo a fare un lavoro per due. Dammi una ragione, solo una, e sparpaglio il tuo fottuto cervello per questa cazzo di stanza. – gli urlò contro. A questo punto schiacciò la pistola in avanti, contro quella stella maledetta, in parte per minacciarlo, in parte per farsi forza.
Come se stesse cercando di convincere sé stesso di quello che aveva appena detto.
Il sorriso storto dell’uomo si fece più marcato e minaccioso. In realtà non era un sorriso. Era un ghigno. Mentre – lentamente – univa le dita dietro i lunghi capelli di corvo, sogghignava sinistramente.
Jeff gli fece scattare le manette ai polsi e agguantò rapidamente la radio.
– Centrale. Qui agente Daniels. Ho arrestato un sospetto nell’appartamento segnalato. C’è bisogno di un’ambulanza per la donna. È ferita…e…credo che sia stata violentata. Chiudo –
Lo spinse fuori dalla camera dopo averlo perquisito. Era disarmato. Non aveva nulla con sé.
Solo lanuggine, sporcizia, tatuaggi inquietanti e quella maledetta faccia da psicopatico.
Mentre passavano in cucina, l’uomo senza nome guardò la donna, si leccò le labbra e, sorridendo, le soffiò un – arrivederci Charline. È stato delizioso. Ci rivedremo presto, ne sono convinto. Molto presto –
Era la prima volta che sentiva la voce di quel tipo. Era profonda e vibrante, come le fusa del gatto della strega. Non era piacevole. Per nulla.
Lei si coprì il viso con le mani e, urlando, riprese a piangere. Jeff si chiese com’era possibile che avesse ancora lacrime da versare. Pensava che le avesse finite da un pezzo.
“Come fa ad avere ancora fiato per urlare?”.
– Muoviti, sacco di merda – gli intimò con uno spintone.
Lo caricò sul sedile posteriore della vettura, dopo di che rientrò nella casa per attendere i paramedici con la donna. La ritrovò seduta al tavolo, in mezzo a quella che fino a poco prima era la sua cucina. Fumava una sigaretta senza filtro facendo una fatica tremenda nell’aspirare il fumo, dato il gonfiore che le deformava parte viso. Piangeva silenziosamente guardando il pavimento.
– Stia tranquilla, signora. È tutto finito. I medici saranno qui tra poco. Avranno cura di lei, mentre io accompagno quella bestia in cella.
La donna annuì silenziosamente senza dare realmente l’impressione di capire ciò che le veniva detto. Sembrava ancora immersa in un’altra dimensione, senza alcuna possibilità di evasione.
– So che non è il momento migliore, ma devo farle alcune domande. Se preferisce posso venire più tardi in ospedale.
Lei scosse leggermente la testa in segno di diniego.
– Va bene, via il dente via il dolore, giusto? – accennò sorridendo.
Non aveva idea di come comportarsi con una donna in stato di shock e quindi il risultato finale fu piuttosto goffo e impacciato. Ma era evidentemente un atteggiamento sincero, dettato dal cuore, quindi la donna gli rispose con un sorriso e un breve su e giù col capo.
– Bene. Mi dica… Conosce quell’uomo?
– No – mormorò appena.
– E non lo aveva mai visto prima di stasera?
– No
Jeff fece un profondo respiro e le chiese se aveva voglia di raccontargli quello che era successo prima del suo arrivo.
– Stavo…stavo preparando la cena. Nulla di speciale. Solo per mangiare qualcosa prima del turno – si interruppe e strizzò gli occhi. Come se ciò che stava ricordando le stesse scarnificando l’anima.
– Poi l’ho sentito… – si interruppe con un singhiozzo.
– Cosa…cosa ha sentito Charline?
La donna non rispose. Aveva i pugni serrati sulle ginocchia e gli occhi chiusi. Le nocche erano viola da quanto stava stringendo la presa.
– Cosa ha sentito, Charline? – la incalzò.
– Un ticchettio… Un ticchettio sulla porta. Come se qualcuno la stesse colpendo con un’unghia del dito.
Si fermò a prendere fiato. Il labbro inferiore tremava.
– Poi ho sentito un sussurro. Mi chiamava. Invocava il mio nome.
Con uno sguardo invasato, posseduta da quel ricordo angoscioso, prese a fissare intensamente Jeff diritto negli occhi.
– ‘Charliiiine…Charliiiine. Apri la porta. Charline, sono qui per te. Sono venuto a prenderti’ – disse replicando con cura angosciante la voce minacciosa del mostro che si era introdotto nella sua casa.
– Ho risposto, pensando che fosse uno stupido scherzo. Quando mi sono resa conto che non era nessuno che conoscevo e quel…quel…quell’uomo continuava a picchiettare e a sussurrare il mio nome, allora ho iniziato ad urlare. Ho minacciato di chiamare la polizia. Ho chiamato i vicini. Poi… –
– Poi…?
– Ha sfondato la porta.
– Come ha fatto? La porta sembra robusta. Ho visto dei segni sullo stipite. Cosa ha usato?
– Le unghie. Ha usato le unghie.
“Okay. È in shock, Jeff. Passa oltre”.
– E dopo che è successo?
– È entrato. Mi guardava fisso mentre si avvicinava. Quegli occhi. Dio mio, quegli occhi.
Si perse nuovamente in un pianto che pareva senza fine. Lui si alzò e le strinse la testa al petto cercando di calmarla. Tra un singhiozzo e l’altro la sentì pignucolare: – Rideva. Mentre lo faceva, rideva, quel maiale. Ho lottato. Non ce l’ho fatta. E rideva. Ancora. E ancora. Le sue unghie, dio mio. Era troppo forte. Troppo. Dio mio –
Alzò lo sguardo su di luì e, con un’espressione sospesa fra terrore e allucinazione, prese a ripetere – Ha detto che tornerà. Tornerà per me. Uccidilo. Ti prego uccidilo. Ma anche se lo ucciderai tornerà. Dio mio tornerà. Oh mio dio. Oh mio Dio –
– Charline. La prego. Lei è sotto shock per quello che le è successo. Si calmi. Tra poco i medici saranno qui – disse cercando – senza troppa fortuna – di calmarla.
Fortunatamente per Jeff, i barellieri arrivarono poco dopo e la portarono via. Anche dopo essere stata legata alla lettiga, continuava a urlare che sarebbe tornato. Sarebbe tornato per lei.
Mentre usciva in strada guardò verso la macchina di servizio e, sul sedile posteriore, vide la sagoma indistinta di quell’uomo. Aveva la sensazione che lo stesse osservando. Non poteva esserne sicuro: la distanza era troppa, e il buio sicuramente non aiutava. Tuttavia, i lampeggianti rossi dell’ambulanza si riflettevano ad intermittenza in due punti ravvicinati, appena dietro il finestrino dell’automobile.
“Cristo, sono i suoi occhi”.
Si autoconvinse che si trattasse di suggestione e respinse a calci dal proprio cervello la voglia crescente di chiamare dei rinforzi per il trasporto.
Pianificò mentalmente di accendere la sirena e dirigersi a tutta birra verso la centrale. In venti minuti sarebbe arrivato. Non era un tempo eccessivo.
“Via il dente, via il dolore”, pensò mentre sedeva rapidamente al posto di guida.
E così, adesso, erano entrambi sull’auto. Con Jeff che se la faceva nei pantaloni e spiava freneticamente nel retrovisore per controllare il suo prigioniero. I lampioni della statale illuminavano il volto dell’uomo solo a metà. Nel buio del sedile posteriore, infatti, si intravedevano a malapena le linee del viso al di sotto del naso. Gli occhi sguazzavano anonimamente nell’oscurità.
Nonostante l’agente Daniels non riuscisse a coglierne lo sguardo, era certo che lo stesse osservando.
Lo percepiva.
– Che hai da guardare? – azzardò
Le labbra dell’uomo in manette si incresparono maligne.
– Ti ho fatto una domanda. Rispondi.
– Guardo la nuca del prode agente Daniels – biascicò rauco – L’uomo che mi ha colto in flagrante mentre me ne stavo seduto su un letto. Davvero eroico – disse prendendosi gioco di lui.
Ogni parola era scandita in modo fastidioso. Era chiaro che anche solo la voce di quell’uomo avesse il potere di fargli torcere le budella. Senza neppure il bisogno di guardarlo.
Jeff era disorientato e infastidito. Una paura insensata gli alitava veleno sopra il cuore. E non c’era verso che riuscisse a spiegarsi l’ansia che gli stava divorando il cervello.
“Lui è ammanettato lì dietro, mentre io sono qua davanti, al volante. Armato” si auto-confortò.
“Lo stai portando dietro solide sbarre d’acciaio spesse cinque centimetri. Stai tranquillo. Non accadrà nulla”.
Ciò nonostante continuava ad avere la sensazione di non avere il pieno controllo su quella situazione.
Come se fosse stato impotente nei confronti di quello strano tizio nascosto nell’ombra.
– Come sai come mi chiamo? Non mi sono qualificato. Come sai il mio cognome? – gli domandò a disagio. L’uomo sorrise ancora. Jeff non riuscì a vedere se gli occhi sorridessero in accordo con il movimento delle labbra, ma covava il pensiero che non ci fosse nessuna gioia in quelle fosse nere.
Sapeva per certo che non c’era nessuna armonia in quell’espressione.
– Quante volte devo ripetermi? Devo fermare la macchina e farti conoscere il mio amico manganello?
Come. Cazzo. Conosci. Il. Mio. Nome – scandì, ormai in ebollizione.
– Ce l’hai appuntato sul petto, agente Daniels. Sul distintivo.
“Merda”. Si sentì mortalmente stupido.
– Ah, giusto. E invece, dì un po’. Qual è il tuo nome? Non hai documenti con te.
– Mi chiamo Enòglie.
– E che razza di nome sarebbe?
– Antico.
– Va bene. Allora…Enòglie, sentiamo… Perché hai aggredito quella donna?
– Charline? Che donna deliziosa – disse con tono sognante.
– Stai attento a quello che dici – gli ringhiò contro.
– Beh. È vero. Una femmina davvero amabile quella Charline…Tu chiedi perché.
Perché, perché, perché…ti serve proprio un perché? Perché mi andava. Perché volevo scopare. Perché volevo picchiare. Volevo vedere che colore aveva il suo sangue. Volevo straziarne la carne e l’anima. Volevo inciderla. Ti bastano come ‘perché’? Ne hai avuti a sufficienza?
– Dio mio… Sì, più che abbastanza – disse Jeff sottovoce.
– E tu perché non lo fai?
– Cosa? Picchiare una donna? – rispose ironico.
Enòglie saettò come un predatore feroce contro la griglia provocando un tonfo metallico. Jeff sterzò per lo spavento, riprendendo quasi subito il controllo. Il cuore gli martellava nelle orecchie paonazze e incandescenti.
– Esatto! E poi riempirla col tuo seme. E tagliarla. Schernirla. Sputarle addosso – disse ridacchiando – Perché non fai il male? –
– Tu sei pazzo.
– Te lo dico io il perché, caro il mio agente Daniels – continuò, ignorandolo – Perché sei debole. Perché non sei libero.
– A me sembra che l’unico ad essere in gabbia, qui, sia tu – rispose Jeff con aria spavalda, cercando di nascondere l’angoscia che gli cresceva in petto come un alieno.
– Non te l’hanno mai detto che il sarcasmo ha la lingua forcuta del serpente, agente Daniels? Non te l’hanno spiegato a catechismo? –
Mentre Enòglie pronunciava queste parole, infilò la punta della lingua tra le maglie della grata sibilando come un cobra. Jeff guardò nuovamente nel retrovisore.
I suoi occhi neri saettavano convulsamente per tutto l’abitacolo. Da destra e a sinistra. In alto e in basso.
Proprio come i pescecani in frenesia alimentare. Quando sentono l’odore metallico del sangue.
– C…cosa c’entra adesso il catechismo? – tentennò.
– Su, agente. Vuoi dirmi che non sei un bravo cristiano? Che non vai a baciare il piediforati ogni domenica? Non ti riunisci insieme alla tua piccola, misera, congrega di cannibali per bere il sangue del redentore?
Bof… Ti conosco meglio di quanto tu non creda, agente Daniels. Una vita casa e chiesa con moglie e figli. Dogmi, regole e leggi da rispettare. Sei un triste essere, agente Daniels. Sei noioso – disse con fare annoiato, lasciandosi cadere con uno sbuffo di pelle sul sedile posteriore.
– E tu, invece? Che saresti? – rispose Jeff scaldandosi. – Tu chi cazzo sei? Che uomo è uno che fa ciò che hai fatto tu? Eh?! Rispondi! Chi è un uomo senza identità, lercio, violento e violentatore come te? Saresti meglio di me?
Ci fu qualche secondo di silenzio, poi la voce roca di Enòglie si raspò una via di fuga attraverso la gola. Esplose rabbiosa, come la piena di un fiume sopito.
– Chi sono? Io sono libertà. Sono divertimento. Io sono anarchia. Non ho né Dio, né patria, né leggi. Non ho amore per niente e nessuno. Nemmeno per me stesso. Io comprendo perfettamente la caducità del mondo che abbiamo intorno. L’inutilità dell’esistenza. Di ogni cosa pronta a farsi stuprare dagli affronti del tempo. Che sia carne, arte, amore, felicità. Bene materiale o spirituale, senza differenza alcuna. Tutto si dissolve e nulla ha senso, per quanto ci possa fare comodo pensare il contrario. Abituatici, figliolo.
Quindi, l’unica cosa che ti resta da fare è abbracciare il nulla. Farlo tuo. Proprio perché nel nulla risiede il senso più profondo: il caos. Quindi, sì, agente Daniels, prendi ciò che vuoi. ‘Scopa, uccidi e caga’, dico io. Domani sarai cibo per vermi. Quindi vai e agisci. Ma fallo ora. E fai ciò che vuoi. Questo è ciò che sono.
– Non sono tuo amico. E tu sei pazzo. Sei completamente pazzo. Non sai quello che dici. Se sei ciò che affermi di essere…o meglio…se hai fatto ciò che hai detto di aver fatto, tra non molto finirai appeso per il collo. E se mi andrà di farlo, potrei addirittura decidere di essere lì per assistere allo show, maledetto bastardo. Anzi, sai che ti dico? Lo farò, te lo giuro.
La risata fragorosa di Enòglie mise in mostra tutti i denti che gli mancavano. Jeff notò – inorridendo – che ne aveva solo una manciata, in quella bocca disgustosa. Sei uncini storti e neri.
– Così mi piaci, mio piccolo, audace poliziotto di campagna. Per una volta sei stato sincero. Così si fa. Abbandonati all’istinto più basso che possiedi e non te ne pentirai – disse ridacchiando – Ad ogni modo non mi fermerà nemmeno lo scorsoio. Tornerò per Charline. Il mio cammino è ancora lungo. Ne ho presi molti prima di lei, e quella puttanella non sarà di certo l’ultima. Quindi non sarai tu ad arrestare il mio cammino. Non tu, né le manette o la pistola. Ricordalo –
– Cosa vuol dire che hai presi altri? Intendi dire che hai ucciso delle persone?
I peli della barba di Enòglie passarono di nuovo attraverso la grata che lo dividevano dal poliziotto. Jeff ne poteva sentire il fiato fetido sul collo.
– Esatto – gli sibilò all’orecchio.
– Stai indietro. Allontanati, o te ne pentirai.
Guardò indietro e vide lunghe unghie nere passare attraverso la griglia metallica. Sembravano degli artigli. Quando gli aveva messo le manette non le aveva notate.
Jeff stava scivolando sempre più a fondo in una situazione paradossale. Un grandguignolesco spettacolo il cui protagonista era personaggio senza alcun senso. Una maschera dell’orrore piovuta da chissà dove per spargere il seme del male e della follia.
Mancavano ormai pochi chilometri alla stazione di polizia, e l’agente Daniels pensò che avrebbe potuto approfondire l’argomento non appena una telecamera avesse potuto registrare la confessione di quel mostro. “Sì…meglio riparlarne dentro una stanza da interrogatorio, con davanti un bel caffè”.
Non lo avrebbe mai ammesso, ma non ne poteva più di quella conversazione. Di quella situazione, di quella serata e di quel maledetto arresto. Non desiderava udire più quella voce nascosta nell’ombra del sedile posteriore. Non tollerava più la vista di quelle unghie da puma, dei denti marci e di quei folli tatuaggi. Voleva solo lasciarlo in custodia ai colleghi e andarsene a casa.
Avrebbe redatto il rapporto in seguito. Così fece.
Il giorno dopo venne a sapere che Enòglie aveva candidamente confessato di aver compiuto la bellezza di trentasette omicidi in giro per tutto il paese. Nelle successive settimane, i dipartimenti federali lavorarono coordinandosi fra di loro per ritrovare i corpi delle vittime che quella belva aveva disseminato per quattro stati diversi. Ne furono ritrovati appena diciannove. Alcuni erano in via di decomposizione, di altri rimanevano solamente le ossa.
Molti erano fatti a pezzi. Ad altri ancora mancavano degli arti. Enòglie sostenne allegramente di averle mangiate. Durante la deposizione ufficiale, cantilenò i nomi dei morti e dei pezzi che diceva di aver divorato seguendo il ritmo di una filastrocca per bambini.
Non furono in grado di accertare la sua identità dato che si era cauterizzato le punta delle dita per rimuovere le impronte digitali. Allo stesso modo, per ovvi motivi, il calco dei denti risultò del tutto inutile.
Era un perfetto signor nessuno. Un vagabondo qualsiasi, un autoeletto emissario del caos, portatore infetto di morte e incubi.
Nei mesi durante i quali si svolse il processo – che Jeff seguiva costantemente sui quotidiani – non riusciva a fare a meno di pensare che l’intera faccenda non avesse alcun senso. Perché Enòglie non aveva ucciso anche Charline quella sera? E soprattutto perché era rimasto seduto sul letto, in quell’appartamento, aspettando che arrivasse qualcuno per catturarlo?
Ne parlò con Gomez e Lewis. Loro erano in polizia da più tempo, e di cose bizzarre ne avevano certamente viste più di lui.
– Alcuni di quei pazzi bastardi vogliono essere presi, Jeff. Anzi, è così per la maggior parte di loro. Mandano messaggi come amanti in calore. Ci contattano, o scrivono ai quotidiani per saziare il loro egocentrismo. “Ehi! Guardatemi! Sono il maniaco primo della classe!”. È successo con Zodiac, o anche con quel pazzo fottuto di Milwaukee. Credo che anche lui avesse telefonato alla polizia locale – abbozzò Gomez mentre Lewis annuiva.
Jeff si fece bastare quella spiegazione, ma senza troppa convinzione. Non ne fu mai convinto per davvero.
Ad ogni modo, Enòglie venne giudicato colpevole per 19 capi di omicidio aggravato e condannato ad essere appeso finché morte non fosse sopraggiunta. Le fotografie sui giornali mostravano il suo volto – dopo la sentenza – felice e soddisfatto, come se non avesse potuto desiderare verdetto migliore.
Il giorno dell’esecuzione, l’agente Daniels era presente tra i testimoni. Non sapeva esattamente cosa lo avesse spinto ad essere lì. Forse la volontà di adempiere alla promessa fatta la notte che lo aveva portato dietro le sbarre. O magari il desiderio irrefrenabile di sentire il suo collo spezzarsi per avere la tranquillità definitiva. La certezza assoluta che il vecchio Enòglie non avrebbe più camminato nel mondo dei vivi.
Che non avrebbe più avuto modo di falciare nessuna vita innocente.
Il palco dell’esecuzione era stato allestito nel refettorio della prigione. Quello spazio era il luogo dove i detenuti si ritrovavano per attività ricreative dove o, nelle feste comandate, si svolgevano le recite teatrali che i reclusi mettevano in scena davanti a parenti e secondini violenti.
Nella sala c’era un intenso odore di disinfettante e zuppa di cavolo.
Davvero un modo pessimo per andarsene.
Davanti al patibolo erano state allineate due ordinate file di sedie. Lo spettacolo di morte poteva iniziare.
Alle 21.30, due agenti di custodia accompagnarono il condannato al patibolo. Aveva i pantaloni grigi della divisa e, sopra di essi, il nulla. Era a torso nudo. Per la seconda volta Jeff si ritrovò ad indagare con lo sguardo su quel corpo allucinante. Scorse una testa di capro che, la prima volta che si erano visti, gli era sfuggita. Ogni costola era segnata da una croce rovesciata. In orizzontale, seguendo le scanalature di quel corpo ossuto, bruciavano tutte. Una tela dell’orrore.
Enòglie entrò sul palco sorridendo, come di consueto, e i suoi occhi presero a frugare avidi fra il pubblico, animati da una curiosità feroce. Come se stesse scandagliando visi di uomini e donne alla ricerca di qualcuno in particolare. Quando vide Jeff, ad appena sette metri sotto lui, il sorriso si allargò a dismisura. Con la piena illuminazione della stanza, la cosa risultava ancor più inquietante e disgustosa. La sua bocca era un pozzo nero adornato da quelle sei schegge grigio-giallastre. Faceva venir voglia di voltare la testa a chiunque osservasse. Jeff sostenne il suo sguardo, seppur con qualche difficoltà: avrebbe voluto fuggire lontano da là. Si pentì di essere andato alla prigione per l’ultimo show di quel demonio.
La corteccia motoria del ragazzo aveva già comandato il movimento alle ginocchia, pronte a guidarlo lontano, fuori da quel posto. Ma qualcosa lo interruppe.
Enòglie, trattenuto dagli agenti di custodia, inclinò leggermente il busto in avanti, e gli sussurrò
– Hai mantenuto la promessa. Bravo. Anche io manterrò la mia. Tornerò. Per Charline –
Poi gli fece l’occhiolino. Dopo di che, prese a fissare il vuoto davanti a lui.
Jeff era livido: avrebbe visto il bastardo morire. Non sarebbe scappato. Non di nuovo. Incrociò le gambe e prese a fissarlo con attenzione, cercando di sfoggiare la sua migliore espressione di godimento. Stava guardando un grosso cono al pistacchio che stava per essere appeso al nodo definitivo.
Adorava il pistacchio.
L’ufficiale addetto all’esecuzione lesse la condanna e domandò all’uomo se avesse delle ultime parole.
Enòglie, udita la domanda, mosse di scatto la testa verso Jeff e disse solamente
– Via il dente, via il dolore. Giusto? –
Poi prese a ridere come se avesse appena pronunciato la più gustosa delle battute.
Era una risata folle, malata e sguaiata. I testimoni rimasero gelati da quella scena, e cominciarono a guardarsi fra loro, smarriti, senza capire cosa diavolo stesse succedendo in quell’auditorium che puzzava di lisoformio, cavolo e morte.
La botola si aprì con uno schianto facendo schioccare la corda come una frusta.
Ma il collo di Enòglie non si spezzò.
I suoi piedi danzavano furiosi, scalciando con malagrazia la ballata degli impiccati mentre continuava a grugnire quella che, in tutta evidenza, era un’angosciante risata strozzata.
Un lungo rivolo di bava biancastra gli segnava la barba. I suoi occhi di tenebra erano vivi. Ridevano.
Per la prima volta Jeff vide una luce là in fondo.
Ballò per loro per circa un minuto e mezzo, fra suoni gutturali e schizzi di saliva. Poi, la stella nera sul suo petto smise di ciondolare, quieta, forse come mai era stata prima di allora.
A distanza di un anno dalla morte di Enòglie, Jeff aveva fatto richiesta di essere messo dietro una scrivania. Il capo non si oppose con troppa veemenza. Sapeva bene che il ragazzo era rimasto bruciato da quella faccenda e aveva intuito quanto il servizio in strada non facesse per lui.
Un giorno, riordinando casa, sotto pile di giornali, trovò sul tavolino del suo salotto una vecchia cronaca del processo. Rivide quegli occhi. Quei due profondi baratri osceni.
L’indomani, pungolato da quel ritrovamento, guidò fino a Hampton Road. Desiderava vedere come se la stesse cavando Charline. Se fosse riuscita a nascondere sotto il tappeto della sua mente la violenza patita per colpa di Enòglie. Se era stata tanto fortunata da aver trovato qualcuno – o qualcosa – in grado di lavare via quello schifo dall’archivio dei suoi ricordi. Anche solo in parte.
Quando suonò al campanello, si meravigliò nel sentire nel suo cuore una viscida patina di angoscia. Stare di nuovo sull’uscio di quell’appartamento lo metteva in agitazione.
“Brutti ricordi” si giustificò.
La porta era stata sostituita, ma lo stipite interno portava ancora i segni della brutalità del lupo cattivo dai lunghi artigli neri. Ad aprirgli la porta fu un uomo sulla settantina.
– Sì?
– Buongiorno, sto cercando miss Harriett.
– Non la conosco – bofonchiò scortesemente il vecchio, incominciando a chiudere la porta.
– Mi scusi…mi dia solo un attimo. Questa donna abitava qui. Probabilmente doveva essere l’inquilina precedente – disse Jeff con una nota di supplica nella voce.
– Io non ne so nulla. Sto qui in affitto da un pezzo. Arrivederci.
Da buon topo da ufficio quale era diventato, fece la cosa più razionale che gli potesse balenare in mente: correre alla centrale e controllare sul proprio terminale che fine avesse fatto Charline.
Mentre guidava la sua Ford bianco sporco verso la stazione di polizia, si domandò se la donna avesse cambiato casa per sradicare dalla sua quotidianità l’evenienza di ricordi spiacevoli.
Forse aveva addirittura cambiato città.
“Molte vittime di violenza tranciano i ponti di netto. Smantellano baracca e burattini e si lanciano verso l’orizzonte, alla ricerca di un nuovo inizio” frullò razionalmente nel cervello.
Raggiunto l’ufficio, si preparò una tazza di caffè e sedette sul suo scomodo trespolo di legno.
Il vecchio macinino che si ritrovava per computer arrancava con una lentezza esasperante mentre lui tamburellava nervosamente sulla scrivania.
Poi, finalmente, apparve il file.
Più gli occhi di Jeff saettavano da sinistra a destra, verso il fondo del monitor, maggiore era il tremito che animava le sue mani.
Lo schianto della porcellana riecheggiò nel vuoto domenicale degli uffici deserti.
Un vapore leggero aleggiava sinuoso sopra schegge di vetro e pozze di liquido nero.
Charline Harriet era scomparsa sette mesi prima.
Emil Brune.