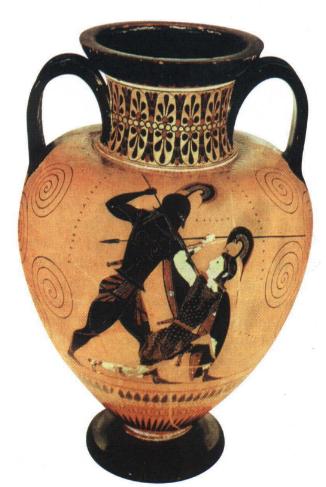La tapparella si alza di scatto con un fracasso da circo e la luce di una qualsiasi mattina inoltrata mi violenta le cornee. Strizzo tra le dita il piumone sbuffando incazzato.
– Alzati, coglione – sbraita Roberta uscendo dalla stanza
Senza preoccuparmi troppo di togliere la faccia dal cuscino le bofonchio di andare a farsi fottere. Speriamo che il suono si sia propagato comunque e l’abbia raggiunta.
“Se solo avessi la telepatia”.
Sciacqua faccia. Radi. Lava l’involucro. Dirigiti – velocità da crociera – verso la cucina per pasto frugale.
Pilota automatico: gran sballo.
Invado la zona fornelli e bacio mia madre
– Ave Mater
– Ave figlio. Frittata? – risponde alzando gli occhi cielo. Non lo ammetterà mai, ma la diverto un mondo. Sappiamo entrambi che è così.
– Mancata prole di pollame, perché no. Mettiamoci anche delle fette di suino, crepi l’avarizia. Un bell’eccidio multirazziale per cominciare l’uggioso giorno – declamo sorridendo.
Mentre si volta verso il frigo per prendere il necessario, abbasso i pantaloni del pigiama, guardo Roberta seduta al tavolo col naso tra i cereali, le mostro la schiena e sussurro un – baaaciamelo – porgendole le natiche nude. Mi guarda con aria divertita sventagliandomi in faccia il medio.
Dolce routine quotidiana. Anche se non sono rotto, mi accomodo a tavola e aspetto il lieto convivio. Con lo sguardo perso nel vuoto, ancora preda del torpore del sonno, avverto una vibrazione sottile che anima il pavimento. Percepisco un rumore in avvicinamento, senza riuscire ad identificarlo. A questo punto mia madre ha smesso di cucinare. Se ne sta lì, impietrita, col mestolo in mano, a guardare noi due.
Nessuno parla. Le uova carbonizzano nerastre.
Dalla porta a vetri della cucina ho una comoda visuale sulla strada. Vedo un’onda dirigersi verso di noi dall’orizzonte. La sento arrivare. Il rombo aumenta. Si espande in ogni direzione mentre segue il suo cammino verso casa nostra, inghiottendo ogni cosa. Bidoni dell’immondizia, pali, cassette delle lettere e passanti spariscono sotto la sua mole. Divora tutto e tutti.
La vedono anche Roberta e mamma. Urlano. Si urla sempre di fronte all’incomprensibile. Davanti all’orrore sfocato non si rinuncia mai a svuotare i polmoni.
Io no.
Resto lì, impalato. Non ho neppure il battito accelerato. Però…cazzo che male in bocca. Sento lo smalto liscio che sfrega.
Cani. Sono…cani. A centinaia, forse migliaia. Di qualsiasi foggia, razza e dimensione. Mastini con bocche ringhianti, Volpini caracollanti che finiscono per essere schiacciati dalla corsa dei Dobermann. Chiwawa rigurgitanti saliva cavalcano Pastori Maremmani come ussari alla carica. È un incendio di peli che nessun canadair potrà mai spegnere. La piena di un fiume pulcioso che, alla fine, si schianta contro la nostra vetrata.
Mia mamma grida di scappare. Di uscire di là. Roberta trema inerme. Io osservo interessato. Placido.
Ma la mandibola inferiore cozza e sfrega con quella di sopra.
“Fanculo che fastidio”.
Ho giusto il tempo di sentire lo schianto di cristalli in frantumi e vedere il volto di mia madre sparire tra le fauci di un Dogue De Bordeaux per poi ritrovarmi in strada.
Non ho idea di come ci sia arrivato. La torma di cani è un ricordo remoto, sfocato, come un sogno raccontatomi da un estraneo un’eternità fa. Mentre eravamo marci d’alcool, per giunta.
Strana sensazione.
Non dovrei essere nervoso, ma le ossa da grugno digrignano e cozzano fra loro. Le sento sbriciolarsi fino a raggiungere la polpa. Me ne rendo conto ma non posso fermarlo. Non sono io a tirare le redini.
Non avrò il controllo della bocca ma, a quanto pare, mi è ancora permesso avanzare. Quindi lo faccio.
M’inoltro verso ovest sul vialetto ordinato. Dopo pochi passi incontro il vicino, il signor chisseloricorda, che innaffia il prato dietro il suo steccato color ‘celeste sogno di fata’.
Che nome stronzo.
– Ma buongiorno, mio giovane amico! – mi trombetta giulivo sotto i baffoni bianchi.
– ‘Giorno – rispondo vago mentre cerco di tirar dritto.
– Ma dove corre così veloce, caro ragazzo? Sì fermi per una tazza di tè…o per una limonata, se preferisce – mentre il suo pancione si svuota d’aria scorreggiando parole, ho l’impressione che qualcosa nella sua voce stia mutando innaturalmente.
– No, grazie, sono di fretta – butto lì allungando il passo.
– Ma lei ha appena avuto una forte scrollata canina presso il suo domicilio! Un’imponente precipitazione canide di livello otto –
Cazzo. Cazzo, merda, cazzo. Merda, cazzo e poi merda. La sua voce…è quella di una bambina. Come se parlasse in falsetto. Un maledetto eunuco da opera.
Per la seconda volta, il mio corpo reagisce alla paura in maniera scoordinata: niente palpitazioni o sudori.
Ma, in compenso, ricevo in premio una scarica di agonia sui quattro incisivi.
“Quasi mi mancava”, penso ironico mentre metto la mano sulla bocca, instupidito dal dolore.
– E poi… non vede che ha i denti a pezzi? Suvvia, sia ragionevole, e si accomodi nel mio domicilio. Da bravo, vedremo di contattare subito un dentista e, mentre aspettiamo, potrebbe bere una limonata ghiacciata seduto sulle mie ginocchia! Che ne dice? – miagola sornione con quella vocetta da bimbetta.
Subito dopo, giuro su dio, quel tricheco bastardo mi fa l’occhietto. Apro la bocca per dirgli che la limonata può infilarsela dove l’aria passa di rado ma, come spalanco le fauci, schegge perlacee e sangue vermiglio saettano ovunque.
Schizzi imporporati toccano il suolo mischiandosi alla polvere. Frammenti d’ebano decorano i ciuffi dell’erba ammaestrata dal flebile vento autunnale.
Urlo. Finalmente urlo.
Alzo il busto dal materasso che sto ancora gridando.
Madre e sorella frullano per la stanza come robottini impazziti chiedendomi se sto bene.
– Tutto okay. Solo uno strano incubo. Non ricordo granché – borbotto.
E vai col pilota automatico. Lava l’involucro. Sbarba le guance. Spazzola la dentatura indolenzita.
Poi, finalmente, l’itinerario prestabilito fino alle uova nel piatto.
Incomincio a carburare e riprendo energia. Lo strascico nerastro di quella follia notturna abbandona il mio cervello, così come il formicolio in bocca.
Mi scrollo di dosso i vaghi incubi della notte precedente, ricordando solo l’agonia dei denti spezzati.
Routine, dolce routine. Il percorso nel mondo degli automi, le lezioni e i caffè, le sigarette in compagnia di discorsi da sagra di quartiere e il chiacchiericcio di sottofondo. Il bla bla bla che arricchisce noi tutti, sfarzosi poveri di idiozia e noia.
Sono in uno stanzone piastrellato in bianco. La luce al neon sopra il tavolone di metallo si riflette sulle mattonelle delle pareti dando vita a un’atmosfera da fantascienza. Addosso ai muri si appoggiano mensole metalliche abitate da strumenti operatori. Storti arnesi da tortura si affacciano dagli scaffali. Becchi arcuati, pinze seghettate, vaschette metalliche e punteruoli mi osservano algidi.
Mia madre è appena uscita, lasciandomi solo con quel corpo livido: sul tavolaccio autoptico riposa quella che fino a dodici ore prima era mia nonna.
Mi avvicino a lei e sfioro appena quelle dita che non potranno più accarezzarmi. Guardandola, comincio a elencare mentalmente tutto ciò che mi è stato strappato via con la sua morte. Se ne vanno i ricordi, alcuni condivisi, altri, per me troppo lontani da raggiungere. Persi nella memoria del bambino che sono stato.
Se ne vanno assieme a questo corpo grigio e stanco.
Spariscono i racconti del passato e libri letti assieme. Non ci saranno più Sir Conan Doyle, Edmond Dàntes o Martin Eden. Le loro storie non prenderanno più forma attraverso la sua voce.
Ne resterà il ricordo, forse.
La realtà intorno a me è vacua e torbida. Confusa. Dentro quel corpo non c’è più nulla. Solo organi inerti, liquidi e gas che presto evaderanno dalle cavità senza alcuna cura o gentilezza: il dispetto finale.
Le accarezzo i capelli e – abituato come sono a vederglieli cadere sulle spalle in eleganti boccoli rossicci – mi fa strano sentirli passare fra le dita. Sono stopposi, sfilacciati e lisci.
Compiere quel gesto inusuale mi frantuma.
“Quale nipote accarezza i capelli della propria nonna?”
Non ha senso. Tutto questo è semplicemente…sbagliato.
“Non voglio che te ne vada”.
Il canino destro mi fulmina con un picco di agonia lancinante.
Per una frazione di secondo socchiudo gli occhi, in attesa che il dolore passi e, quando li riapro, la sua testa è piegata su un lato, verso di me. Mi osserva, silenziosa. La morsa d’acciaio dell’ansia stritola i miei polmoni. “Dev’essere un sogno. Deve esserlo”.
Poi, sorride. Stordito, le sorrido di rimando.
– Ma…che…ma che diavolo succede?
– Shh, da bravo. Fatti dare un’occhiata prima di andare.
– Ti voglio bene, nonna – sussurro con un alito di voce al cui interno c’è tutto me stesso.
Quegli occhi nocciola, che sono anche i miei, mi regalano un ultimo saluto. Nelle loro profondità c’è l’amore abissale, che non teme né le ingiurie del tempo né l’eternità della morte. Desidererei che potesse restare qui, per sempre, ma mentre rimette la testa in posizione e chiude gli occhi, so che non le è permesso. Deve rispondere – come tutti – al comando più grande. Così la lascio andare.
La luce del neon traballa mentre piango. Mi inginocchio continuando a stringere la sua mano gelida.
“Non andare. Non ora. Resta con me”.
Il neon smette di sfarfallare. Tra le lacrime che mi offuscano la vista, osservo il mio canino insanguinato sul pavimento.
Lanciando via le coperte sudate, sento ancora addosso il peso una tristezza ignobile. Di quella malinconia bastarda che si intorbidisce nel cuore. I miei denti sono in fiamme, poi, ricomincia lo show: via la barba, lava il sottobraccio, sciacqua il volto. Trascinati – come lo zombi che sei – verso tristi fiocchi d’avena.
Mentre mangio, guardo il muro, apparentemente disconnesso.
– Stanotte ho sognato nonna – annuncio cupo.
– Capita a tutti, credo – risponde Roberta senza alzare lo sguardo.
Stramaledetta routine. Perdi la cognizione del tempo e dello spazio. Stessi luoghi, stessi volti. Inabissati negli schermi sociali, perdi quotidianamente la dignità esibendoti come un pavone daltonico. Rinuncia a serenità e al desiderio di contatto. E allora vai, cammina tronfio, ostentando apparenza. Incazzati come un demonio quando la cassetta degli attrezzi non si chiude più. Cacciaviti, tenaglie e brugole non ritornano docilmente al loro posto, quasi fossero i pezzi sconnessi della tua vita.
Apro internet e navigo tra sogni di denti. Nulla di buono: lutto, mancanza, morte di persone care e via dicendo. “Ottimo. Non potevo desiderare di meglio”.
Denti. Denti. Denti.
Continuo coi miei sogni di dentina in frantumi e polpa esposta e sanguinante. Sento l’aria gelida scorrermi tra i tronconi dei cadaveri bianchi che ho in bocca. Notte dopo notte.
Sono in uno spazio buio. Passo la mano davanti agli occhi ma non riesco a vederla. Provo ad alzarmi, ma non ci riesco. C’è un muro a trenta centimetri dal mio corpo. Sono disteso fra due pareti d’acciaio.
Poi, cristo, una forza mostruosa mi scaraventa all’incazzata a destra e poi a sinistra, manco fossi in una centrifuga. Sento nuca e schiena sfregare sul pavimento mentre brandelli di carne prendono commiato dal mio corpo. Va avanti così per un tempo senza limite.
Dopo di che, pesanti – e colorate – forme geometriche cominciano a lampeggiare nell’oscurità. Mi vengono bruscamente incontro, per poi fermarsi immediatamente davanti agli occhi.
“Mi schiacceranno. Cazzo, mi spappoleranno al suolo. Mi disintegreranno”.
La bocca mi viene spalancata a forza. Qualcosa di cilindrico e zigrinato mi scava fra le labbra: ho decisamente un tubo tra i denti. Vengo sballottato così, senza sosta, a destra e sinistra. Il dolore è insensato. Sento i denti disintegrarsi per lo sfregamento abrasivo. Proprio quando penso di stare per morire dall’agonia, la forza si placa, lasciandomi sospeso in quell’incubo nero.
Respiro all’impazzata per lo shock. Nuove corone spuntano espellendo i monconi insanguinati. Poi ricomincia. Lancette invisibili scorrono incalcolabilmente durante la tortura. Svengo. Non sento più nulla.
Quando riprendo i sensi sono ancora avvolto dal buio. Vorrei urlare, ma non posso: i denti sono ormai troppo lunghi per permettere alla mascella di articolare qualsiasi movimento.
Mi sveglio e sono sereno. Tutto è passato non appena ho aperto gli occhi. Niente dolore sulle arcate, né ansia o preoccupazione alcuna.
Io sono lexotan.
Mi alzo a fatica, ma riesco comunque a mettermi seduto, nonostante le braccia mi strozzino il torace.
Non ci sono più quadretti con volti sorridenti alle pareti. Niente computer, bandiere, foto, boccali da birra o sorelle che mi svegliano scherzando. La luce dell’alba che filtra attraverso la grata della finestra illumina un paio di pantofole bianche e spente pareti grigiastre.
Nel mio abbraccio forzato, con le mani appena sotto le scapole, mi osservo allo specchio.
Le cinghie tintinnano.
Guardo le mie labbra distrutte, poi…spalanco. Scruto nelle ritmiche cavità, e mi dò il buongiorno col mio migliore – e roseo – sorriso.
Finalmente sono libero.
Emil Brune