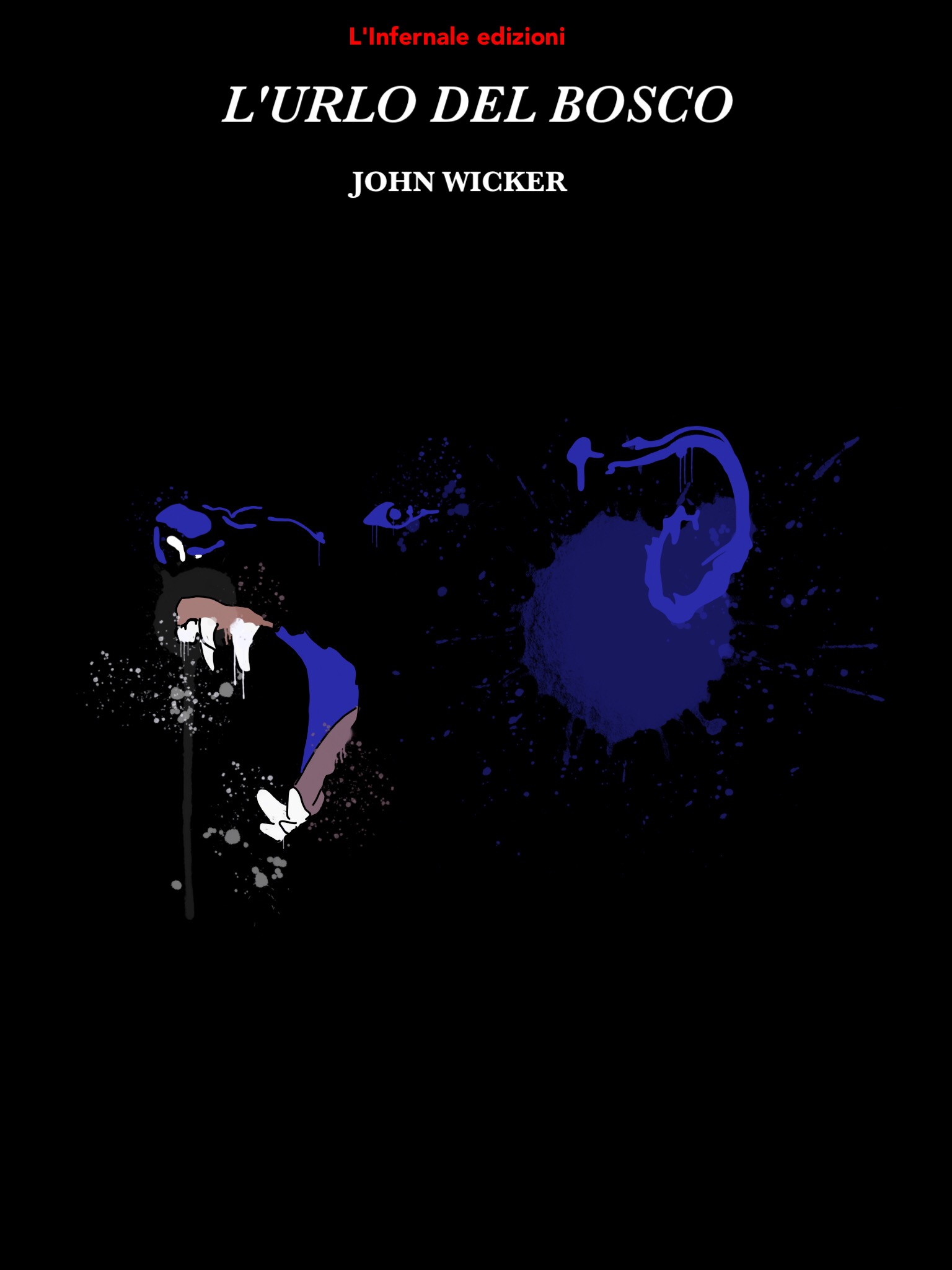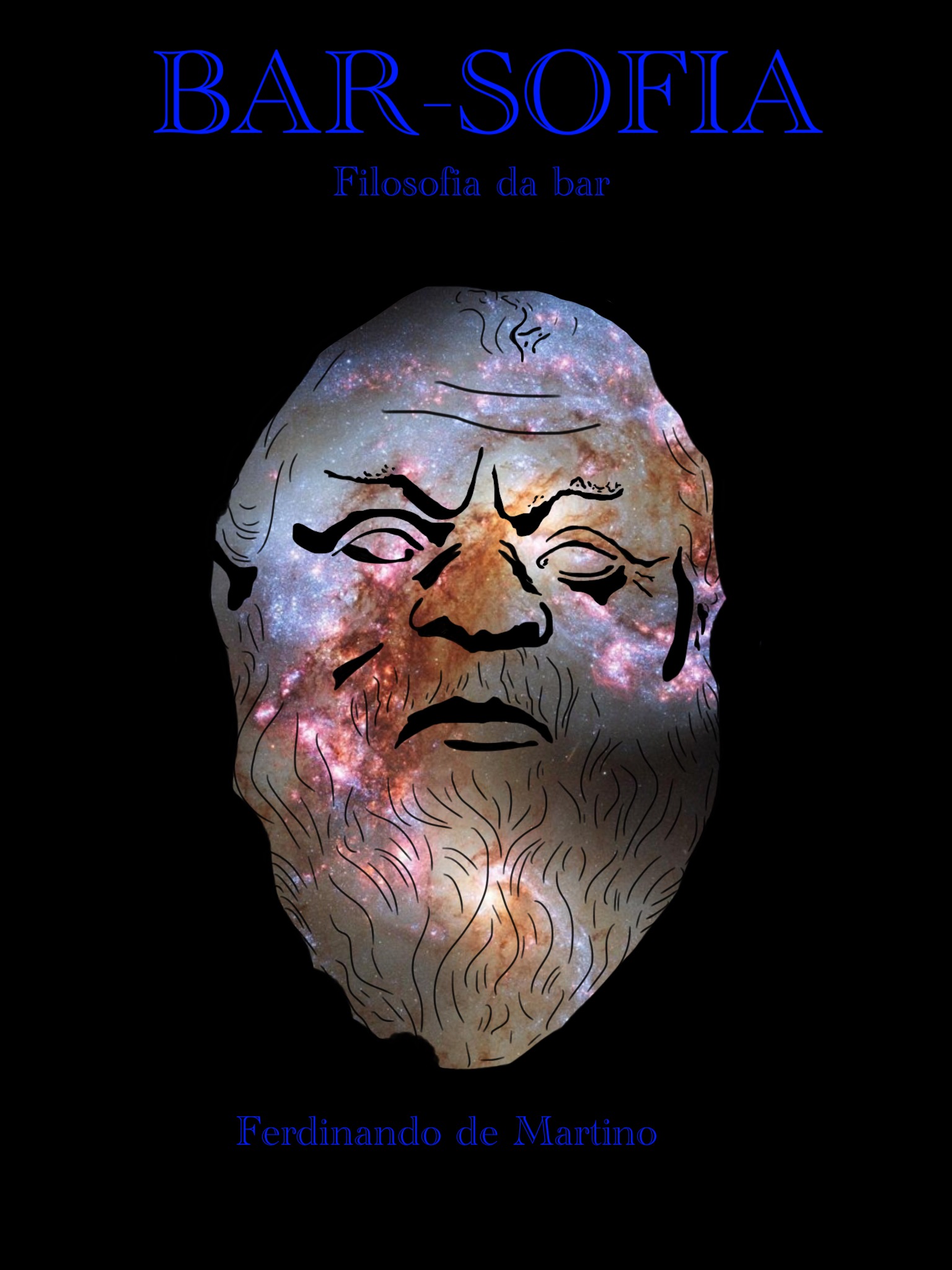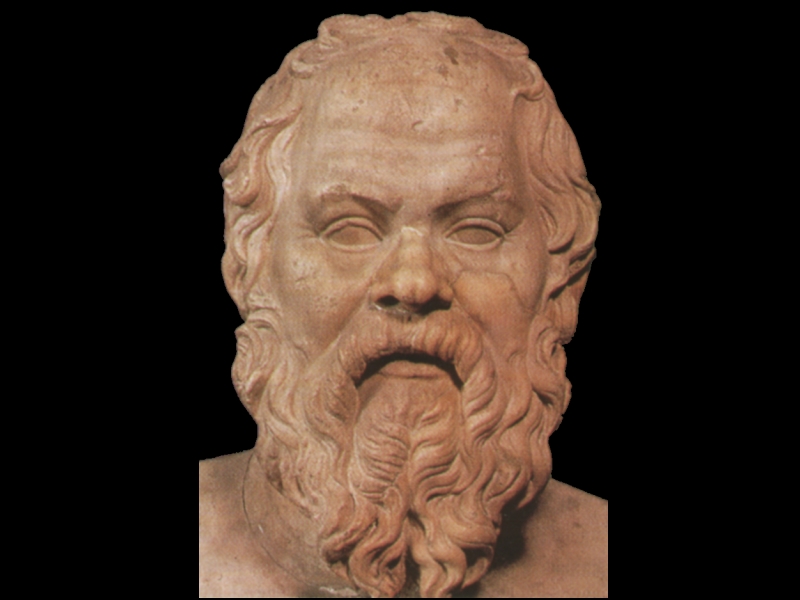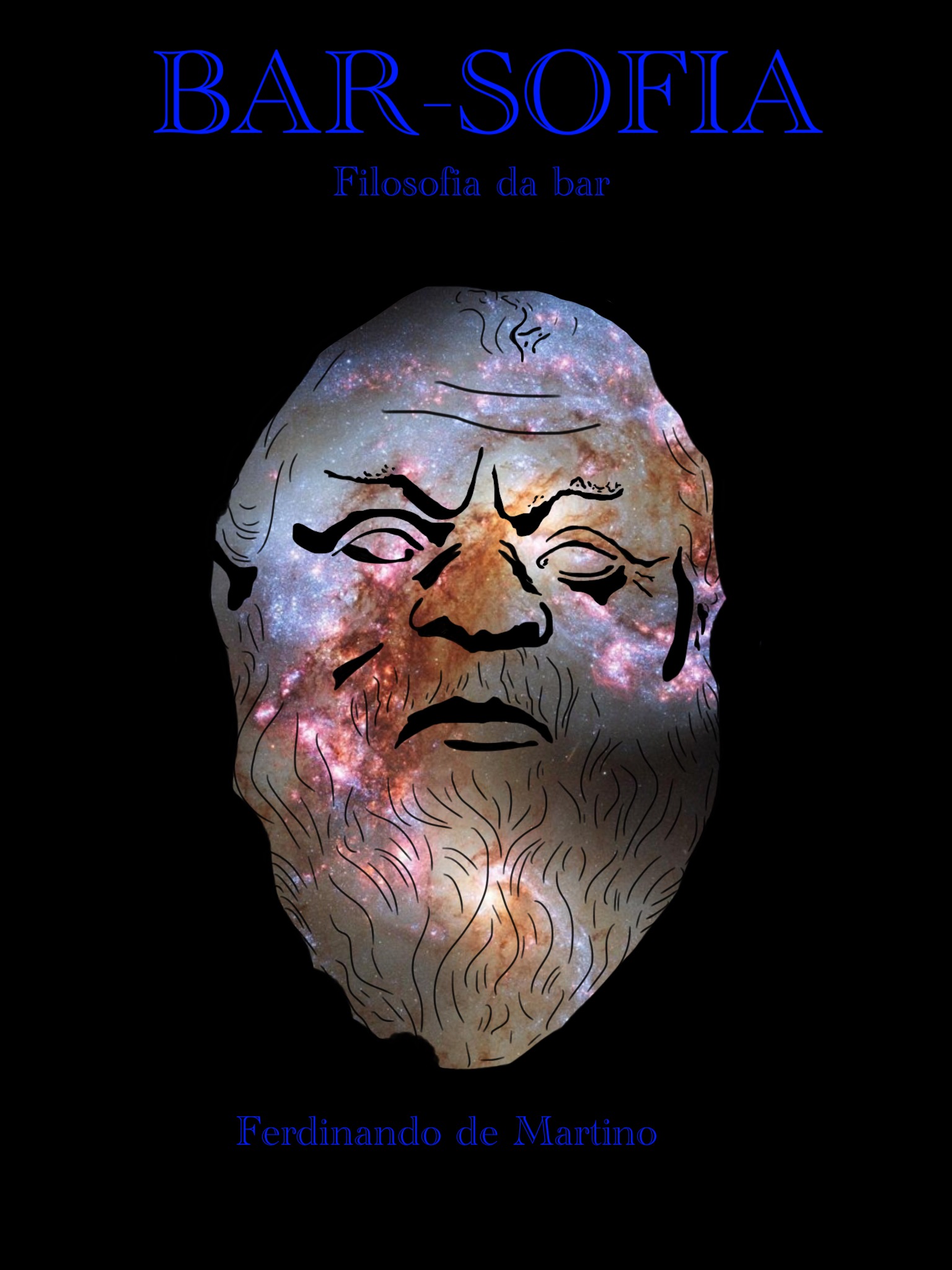
Il bar come concetto.
Il bar è uno dei più grandi cliché della narrativa. Cinema, letteratura tradizionale e a fumetti, televisione e teatro tendono ad utilizzare, spesso, il bar più come una sorta di concetto che come un luogo vero e proprio.
Se in un racconto o in una puntata del vostro serial preferito, un investigatore privato si trova all’interno di un bar è per via degli stereotipi che la sua figura rappresenta, rapportata al concetto di bar.
L’investigatore, al contrario del poliziotto, è quasi sempre un outsider (come spiega Poe in uno dei suoi saggi di scrittura) e come ogni outsider che si rispetti, scappa sempre da qualcosa; questo “qualcosa” potrebbe essere un passato da dimenticare, dei cari persi in qualche strano incidente e via dicendo. L’epicentro del discorso è “lo scappare”.
L’investigatore scapperà sempre da qualcosa o da qualcuno. Ora, l’escamotage del bar attribuisce allo “scappare” una nota di tragedia interiore; come se il bar fosse l’unico posto in cui l’investigatore può permettersi di “scappare” senza muoversi.
Quell’uomo avvolto dal suo trench, potrebbe bere in casa sua o addirittura nel suo studio, ma no… lui preferisce il bar.
BAR+INVESTIGATORE, genera TRAGICITÀ
Ogni figura, nella narrativa, ha una sua personale connotazione all’interno del bar. Una donna altolocata, che solitamente entra in un bar sempre e solo per cercare qualcuno, controllerà la polvere sul bancone e scruterà con sdegno il bicchiere di Coca Cola o acqua, che ordinerà solamente per educazione e non per sete.
L’arte, al contrario della filosofia, dev’essere lo specchio della società, mentre la filosofia rappresenta la lente d’ingrandimento di questa. Ecco perché l’arte e la filosofia sono da sempre alleate. In fin dei conti, sempre di lenti si parla.
Essendo l’arte, specchio dell’intera società, la riproduzione artistica del bar deve, in qualche modo, rifarsi all’idea reale di bar. Questo vuol dire che il bar, altro non è che un luogo atto a stereotipizzare ogni individuo? Esatto.
Il bar è la perfetta riproduzione di una piazza greca. Al giorno d’oggi esistono molte piazze, Facebook è l’emblema di queste, ma al contrario del noto social network, il bar riesce a tirar fuori le nostre debolezze, cosa che Facebook cerca di eludere, mostrando i nostri bicipiti e le nostre cosce mentre fingiamo di essere ai Caraibi, durante un pernottamento a Spotorno.
Nei bar tutti hanno qualcosa da dire e lo fanno coi loro atteggiamenti.
Immaginate di trovarvi in questo preciso istante all’interno di un bar, diciamo… con un paio d’amici, intenti a farvi una birretta.
Vedete quel gruppo di ragazzi, lì? Due tavoli a fianco al vostro? Bene.
Sono in cinque e tutti stanno chiacchierando. L’argomento non è importante, quello che è importante è l’atteggiamento.
Se all’interno della comitiva, qualcuno inizierà ad alzare il tono della voce, magari ridendo o scherzando, ecco, quello è l’individuo più solo del gruppo. Ovviamente non sto parlando di un singolo episodio, ma di ripetute dimostrazioni di superiorità canora che andranno a dimostrare quanto da me sostenuto.
Che bisogno c’è di alzare la voce? Che bisogno c’è di essere quello che grida più di tutti, quando segna l’Inter? Che bisogno c’è di ordinare da bere con voce gutturale? La risposta è una ed una soltanto: la solitudine.
Il bar tende ad estremizzare tutto, specialmente quando si passa al secondo bicchiere; solitudine, terrore, amore, invidia, perfidia, tutto verrà estremizzato da quell’ambiente in cui la competizione è silenziosa e serpentina.
Molti sarebbero portati a credere che il più solo del locale sia il tizio che inizia a raccontare la propria vita al primo sconosciuto, ma non è così, in quanto chi ha qualcosa da raccontare, raramente alza la voce. Le tonalità alte rappresentano l’arma di chi non ha un cazzo da raccontare, perché quel poco che si ha, lo si cerca di vendere in maniera altisonante.
La voce degli ambulanti che gracchia dagli altoparlanti -Donne è arrivato l’arrotino.-, ne è la dimostrazione più eloquente.
Credetemi, amici… il bar smaschererà tutti, se gli darete il tempo di farlo.
Tutto il mio discorso si basa sull’apparenza e molti di voi saranno portati a pensare che giudicare dall’apparenza sia uno degli errori più grossolani per una persona. Beh, chi la pensa così, commette un grossolano errore di calcolo.
È stato M. Heidegger a dire -Ciò che non si manifesta nel modo in cui non si manifesta l’apparenza, non può neppure sembrare, esser parvenza.-, ed io la penso esattamente come lui.
L’apparenza descrive alla perfezione l’individualità dell’essere. Dall’apparenza possiamo dedurre i gusti musicali, le ideologie politiche e perché no, anche le tendenze sessuali.
Possiamo tranquillamente asserire che l’apparenza è, a tutti gli effetti, la carta d’identità dell’essere.
Il bar rende più semplice risalire all’essere, enfatizzando l’apparenza.
Addentrandosi in questa foresta di pensieri, si potranno scoprire una miriade di nozioni che potranno tornare utili all’animale da bar.
Il mercoledì sera, ad esempio, è più semplice rimorchiare nei bar. Prima di darmi contro, pensate a tutte le volte in cui avete rimorchiato in un bar o, se non è mai successo, pensate a tutte le volte che i vostri amici hanno rimorchiato all’interno di un bar. Quanti di questi rimorchi hanno avuto luogo durante un mercoledì sera? Ecco.
Il motivo è semplice ed è estremamente radicato nella filosofia da bar: siamo la generazione della pausa.
Siamo i messicani delle generazioni. Prima di additarmi come razzista per aver sostenuto che i messicani siano pigri, lasciatemi il tempo di spiegare questa mia affermazione.
Chiunque sostenga che i messicani non sono pigri, o non ha mai conosciuto un messicano o non ha mai ragionato sulla derivazione del termine, spagnoleggiante, “siesta”. Se questo non bastasse, vi porterò un altro esempio.
I messicani hanno inventato uno strumento musicale chiamato Kahon, strumento che consiste, praticamente, in una scatola su cui sedersi. La musica nasce dal battere le mani sulla suddetta scatola. Ok. Dopo aver dimostrato di non essere razzista, ma solamente obbiettivo, posso tornare al saggio.
Siamo la generazione della pausa. I nostri videogiochi hanno sempre la possibilità di fermare il gioco per fumare una sigaretta e se credete che sia sempre stato così, non avete mai giocato a Pac-man.
Pac-man non aveva l’opzione pausa. Pac-man ti logorava il cervello. È per questo che i rimorchiatori degli anni ottanta uscivano di sabato e non di mercoledì; perché il fine settimana era dedicato al divertimento.
La nostra generazione ha bisogno di una pausa settimanale per “tirare avanti” e così, il mercoledì è diventato il giorno designato a questa pausa dallo stress della vita. E cosa fanno le donne quando sono stressate?
Adesso, probabilmente, mi ritroverò nella merda fino al collo: ehi, dopo i messicani non vorrai mica stereotipizzare anche le donne?
Amici, le regole del gioco non le ho fatte io… è stato il bar. Quel posto con le insegne luminose, tira fuori la verità dalle persone e se le donne sono più inclini a scacciare lo stress facendo l’amore non è colpa del sottoscritto. Gli uomini farebbero l’amore anche per scacciare l’amore stesso. Visto? Siamo tutti degli stereotipi, no?
Il teorema del triangolo.
(il gioco dell’istinto)
Lo scopo di questo libro è il seguente: analizzare la società, utilizzando il metro del bar.
Molto spesso, alleggerendo il nostro modo di ragionare, finiamo per lasciarci guidare dall’istinto. Quella spinta inconscia che provoca, negli esseri viventi, reazioni e risposte immediate agli stimoli esterni.
L’istinto fa parte del nostro animo più ancestrale, ovvero, quello che ci lega in maniera stretta ed indissolubile al genere animale. Preso da un punto di vista scientifico, l’istinto, non andrebbe mai lodato, in quanto prerogativa innata di ogni essere vivente. L’istinto non si può allenare come si farebbe con un muscolo e a chiunque sostenga il contrario, potrei rispondere in tutta tranquillità che credere di poter allenare l’istinto è del tutto simile al credere di poter allungare il proprio pene, seguendo un blog su internet.
Quando annusate un qualcosa di estremamente maleodorante, l’istinto sarà quello di allontanare il suddetto oggetto dal vostro naso. Questo perché, ad un livello teorico, ciò che profuma dovrebbe essere meno pericoloso di ciò che puzza.
L’istinto ci fa fare in un nano secondo, quello che il ragionamento meditato e filosofico ci farebbe fare in tre o quattro secondi. Perché, allora, parlare dell’istinto in questo libro se l’intento è quello di spiegare la “filosofia” da bar? Semplice: perché l’istinto può portare a delle scoperte molto interessanti, dal punto di vista filosofico.
Chiunque abbia bazzicato l’ambiente dei bar, è consapevole del fatto che, prima o poi, qualcuno finirà col raccontare al barman i propri problemi. È un dato di fatto. Può trattarsi di un problema sentimentale, di una sconfitta sportiva, un licenziamento e via dicendo… tutti, prima o poi, finiscono col raccontare i propri drammi al loro oste di fiducia.
Ci si siede al bancone, si ordina qualcosa di virile o simil-virile e si dà il via ad un monologo incentrato sul mondo e sulla sfiga, entrambi elementi che sembrano essersi messi d’accordo contro il malcapitato.
All’interno di questa equazione c’è un’incognita: lo sgabello. Eh si, perché gli sgabelli dei bar ballano sempre. Mettetevi nei panni d’un povero cristo, uno che ha perso il lavoro dopo aver perso la fidanzata e dopo aver scoperto di non poter più pagare le rate della macchina; pensate alla sfiga tremenda, trovi un barista con cui sfogare il tuo odio verso il mondo e lo sgabello su cui sei seduto non ne vuole proprio sapere di star fermo.
L’istinto ha portato, almeno nel sottoscritto, a sviluppare una sorta di senso di ragno (alla spiderman), atto a testare col sedere uno sgabello, prima di sedersi. In pratica, si finge di appoggiarsi qua e la, fino a quando non si trova lo sgabello meno traballante.
Un giorno, questo mio istinto di sopravvivenza alcolica, mi aiutò a sviluppare il teorema del triangolo o “il gioco dell’istinto”.
Mi trovavo in un bar, pronto a chiacchierare con una barista niente male, quando appoggiando il sedere per testare la stabilità di uno sgabello, notai qualcosa di strano. Quello era decisamente lo sgabello più stabile dell’intero pianeta. Come diavolo era possibile? Semplice. Abbassando lo sguardo, mi si aprì un mondo.
Duemila anni e passa di evoluzione, ecologismo, software incredibili, nanotecnologia, bombe atomiche, penicillina, porno gratuito e davvero il mondo ancora non aveva capito qual era la soluzione al traballamento generale di sedie e tavolini di tutto l’intero pianeta?
L’uomo, lo stesso animale che aveva inventato la ruota, non riusciva a trovare soluzioni migliori dell’utilizzo di un libro, per impedire alla gamba di un tavolo di rovinare una cena?
Incredibile. Davvero incredibile.
La soluzione a questo dramma da taverna è estremamente banale. In un futuro prossimo, potremmo risparmiare tonnellate e tonnellate di legname, dando vita ad una nuova politica del risparmio sulle gambe dei tavolini, degli sgabelli e delle sedie; perché il numero ottimale di gambe per una sedia, sgabello o tavolo che sia è tre.
Pensateci bene, se le gambe di una sedia fossero tre, non avrebbe importanza nemmeno la misura di queste, in quanto risulterebbe impossibile far ballare una qualsiasi struttura, appoggiata su tre gambe.
Senza il mio istinto non avrei mai capito questa stronzata. Infatti, sebbene il numero tre sia molto importante sotto svariati aspetti, uno su tutti è sicuramente quello che ne fa il primo numero in grado di costituire una maggioranza ed una minoranza all’interno di un gruppo, non è questo il punto centrale del mio ragionamento.
Il teorema del triangolo, serve esclusivamente a spiegare che il ruolo dell’istinto è di basilare importanza in ambito filosofico, perché l’istinto, essendo un tutt’uno con la paura e con le nostre memorie ataviche, spesso ci può fornire in maniera del tutto gratuita lo spunto per interpretare meglio ciò che ci circonda.
Insomma, il bar è solamente un metro di misura, mentre l’istinto è ciò che può smuovere i pensieri, proprio quando avevamo deciso di alleggerire il peso del ragionamento. L’istinto, in questo caso, è una sorta di assicurazione sull’utilizzo del pilota automatico.
Se solo ci fosse un modo semplice e razionale per capire quando il nostro cervello inizia a remarci contro, focalizzandosi esclusivamente sul problema, senza cercare una soluzione apparente, tutto sarebbe più facile. Pensare meno e affidarsi totalmente all’istinto non è una soluzione, in quanto istinto e ragionamento viaggiano di pari passo, un po’ come l’apollineo e il dionisiaco.
Applicare il ragionamento a ciò che l’istinto ci mostra è l’unica strada che può portare a mirabolanti scoperte come, ad esempio, quella del teorema del triangolo.
La questione del demone egizio.
M. Heidegger nutriva una forte avversione verso l’avvento delle nuove tecnologie. Molti studiosi sostengono che questa sua idiosincrasia sia da ricondurre al periodo storico in cui il filosofo ha vissuto.
La tecnologia viene da sempre progettata per essere impiegata in ambiti in cui vi è una forte richiesta d’impiego e ai tempi del vecchio Martin, l’impiego più utile (se di utilità si può parlare in una situazione del genere) era la guerra.
La meccanizzazione della guerra è un fenomeno a cui, ai nostri giorni, siamo del tutto assuefatti, ma durante la seconda guerra mondiale questo procedimento deve aver, sicuramente, destato non poca curiosità da parte del mondo accademico.
Per la prima volta nella storia dell’umanità la freddezza del metodo sperimentale veniva messa al servizio di una grande macchina della morte.
Ma ciò che interessa a noi è la filosofia da bar, dove vuoi andare a parare, dunque? Datemi un momento e tenterò di arrivare ad estrapolare un concetto da queste pagine.
Sempre Heidegger, grande esistenzialista, ha scritto uno dei più importanti tomi di filosofia del novecento: Essere e tempo.
All’interno di questo libro, il filosofo, si pone una domanda che, sin dall’antica Grecia, ha messo in ginocchio la filosofia: cos’è l’essere?
Bella domanda. Cos’è l’essere?
Proprio da questa domanda, Heidegger, ci regala una perla di saggezza inestimabile. Da questa lezione ho imparato una verità sconcertante, per una mente come la mia, che di filosofia non so praticamente niente.
Quando ci poniamo la domanda in questione, ciò che sbagliamo non è la domanda in sé, quanto più la forma. Se domandiamo a qualcuno -Cosa è l’essere?-, finiamo automaticamente a catalogare “l’essere” come ente. Questo è uno dei più grossolani errori della società.
Il vecchio Martin, dunque, sostiene che l’essere non si possa ridurre ad ente, in quanto l’essere è tale, proprio perché si manifesta esclusivamente nell’ente.
Molto spesso non sono le domande ad essere sbagliate, ma solo la loro forma e, purtroppo, la forma è strettamente legata al significato.
Prendiamo, ad esempio, la domanda: si può analizzare la vastità della società contemporanea in un microcosmo come può essere il bar?
Anche in questo caso non è la domanda ad essere sbagliata, bensì la forma. La domanda giusta è: si può analizzare il bar, rapportandolo alla vastità della società contemporanea che si esprime al di fuori del suo microcosmo? È la risposta a senza alcun dubbio: sì.
Bisogna pensare al bar come ad un ente preso a caso. Potevamo servirci della scuola, dell’università, di un centro commerciale e via dicendo… io ho scelto di utilizzare il bar, per la connotazione pop che ha assunto all’interno del nostro immaginario collettivo.
In questo caso dobbiamo pensare al bar, come ad una rappresentazione contemporanea del mito della grotta di Platone.
In pratica, ciò che vediamo all’interno del bar, altro non è che il contorno delineante di un qualcosa che a stento possiamo immaginare, ma di cui possiamo analizzare il rapporto con la società esterna in quanto, al contrario del mito di Platone, noi dal bar possiamo uscire quando ci pare e piace.
Ora, grazie a Socrate riusciremo a mettere insieme i pezzi di questo puzzle di concetti.
Al momento sappiamo che: Heidegger non amava la tecnologia.
Abbiamo imparato ad osservare bene la struttura di una domanda.
Stiamo utilizzando il bar per rilevare le ombre della società che vogliamo andare a razionalizzare.
L’avversità nei confronti della tecnologia di Heidegger, acquisisce un’attualità quasi sconcertante, se si va ad analizzare uno dei più particolari discorsi di Socrate, ovvero, “il demone d’Egitto”.
Ve la farò molto breve. In pratica, Socrate raccontò di un certo Theuth (demone egizio) che di tanto in tanto si dilettava nell’inventare. Un giorno inventò, ad esempio, l’astronomia, un altro giorno inventò la geometria, la scrittura e il gioco d’azzardo coi dadi.
Queste sue invenzioni vennero, da lui stesso, mostrate al re d’Egitto Thamus. Quando si arrivò alla scrittura, Theuth si trovò davanti ad un muro di cinismo, costruito dalla saggezza del sovrano d’Egitto. La scrittura doveva servire come Viagra della cultura e della memoria (detto alla buona), tuttavia Thamus denigrò a gran voce questa subdola invenzione, regalandoci una chiave di lettura che tutt’ora mi fa dubitare molto spesso del mio lavoro.
La scrittura, secondo Thamus, avrebbe distrutto la memoria stessa del popolo egizio che, abituato a dover tenere a mente tutta una serie di concetti, avrebbe iniziato a scrivere questi concetti per tenerli meglio a mente, al posto d’impegnare la loro memoria a contenere i suddetti concetti.
Questa storiella di Socrate, ci fa capire quanto il saggio ateniese fosse riluttante nei confronti della scrittura.
Abbiamo, quindi, la scrittura, la tecnologia, il bar e la società contemporanea. Adesso non ci rimane che dar vita ad un “demone”che avrebbe fatto incazzare a dismisura sia Socrate che Heidegger, ovvero, una sorta di ibrido tra letteratura e tecnologia. Lo smartphone, anzi, lo smartphone rapportato al bar.
Grazie al recente sviluppo della tecnologia mobile, ciò che è scritto è alla portata di chiunque in qualunque momento e se ponete una domanda del tipo: “chi è David Bowie?” basteranno una manciata di minuti, ad un qualsiasi individuo, per imparare vita, morte e miracoli del cantante inglese.
Questo potrebbe sembrare un enorme traguardo dell’umanità e in un certo senso lo è, perché se venite morsi da un serpente, grazie al vostro telefono potrete individuare la tipologia di rettile che vi ha morso mostrandola al vostro medico; ma provate a chiedere alla stessa persona, dopo dieci minuti: in che anno è nato David Bowie?
Probabilmente l’individuo in questione vi risponderà -Aspetta che vado a controllare su internet.-. Ecco la dimostrazione che, anche se da un certo punto di vista la nostra vita è notevolmente migliorata, i dubbi di Socrate e Heidegger non erano del tutto infondati.
Avendo imparato che il bar, generalmente, rappresenta una visione alleggerita di una società esterna che, a tutti gli effetti, si arrovella dietro a problematiche più importanti dei compleanni delle rockstar, questa dilagante ondata di qualunquismo tecno-letterario mette davvero i brividi.
Avevano ragione Socrate e Heidegger, quindi? A questo quesito non possiamo rispondere.
Quello che possiamo fare, invece, è l’immaginare un Socrate contemporaneo. Una buona domanda da porsi è: come vivrebbe Socrate nella società contemporanea?
Se si conosce anche a grandi linee la vita di Socrate, non si può dubitare del fatto che il sommo ateniese non avrebbe mai resistito alla possibilità di rompere le palle ad individui che situati in continenti lontani miglia e miglia dal suo, grazie al web.
Ebbene sì. Socrate avrebbe amato a tal punto Facebook da diventare un generatore automatico di spam sulle più disparate accezioni della morale.
Le nostre bacheche sarebbero piene di domande tipo <<Cos’è una buona azione?>> o,<<Definisci la bellezza.>> e via dicendo.
Socrate avrebbe scritto, affrontando il nostro tempo esattamente come affrontò la guerra, il processo per empietà e perfino la sua condanna a morte, ovvero, con estremo rispetto ed eleganza interiore, senza mai abbassare la testa.
Detto questo, Socrate dev’essere stato un rompi coglioni di proporzioni bibliche e in un bar qualsiasi, sarebbe finito in duelli senza fine coi vari Diogene da bancone.
Ferdinando de Martino.